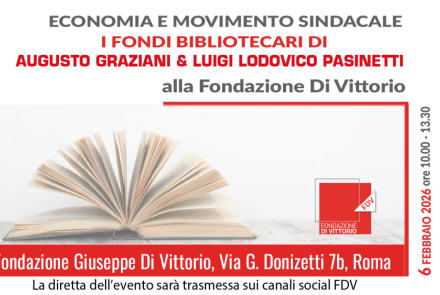L’eredità di Pietro Ingrao: la ricerca sulla emancipazione umana
Articolo originariamente pubblicato su Left.it al link https://left.it/2025/11/13/leredita-di-pietro-ingrao-la-ricerca-sulla-emancipazione-umana/
Rivedi il convegno al link: https://www.youtube.com/watch?v=8vRwqjTW1B0
Nell’ultima fase del suo impegno politico, Ingrao rilanciò un comunismo antidogmatico, qualitativo e profondamente umano, capace di sfidare capitalismo, statalismo e le nuove contraddizioni del nostro tempo. Per rileggere la lezione politica di Pietro Ingrao pubblichiamo l’intervento dal titolo”Tenere aperto l’orizzonte del comunismo: la ricerca sull’emancipazione umana nell’ultimo Ingrao” del ricercatore della Fondazione Di Vittorio Mattia Gambilonghi durante il convegno “Pietro Ingrao, dalla terra alla luna, scavando dalla polvere” che si è svolto il 13 novembre al Senato.
Il punto di partenza per un ragionamento intorno ai tratti, alla precisa curvatura che assume in Pietro Ingrao la ricerca intorno alle forme dell’emancipazione umana nell’ultima fase del suo impegno politico in prima linea, come dirigente ma soprattutto attore, come protagonista di quella sinistra che – all’indomani dell’89 e nel pieno dell’egemonia neoliberale sul piano dell’immaginario e del senso comune – nonostante ciò tiene viva una postura critica rispetto all’esistente, un anelito alla trasformazione radicale dello status quo, delle sue contraddizioni e dei suoi meccanismi di sfruttamento, alienazione e negazione dell’individualità umana: il punto di partenza, dunque, di una riflessione sui modi con cui Ingrao tenta di “tenere aperto l’orizzonte del comunismo” – come dirà in occasione del suo intervento al XIX congresso del Pci, il primo della svolta apertasi al quartiere della Bolognina all’indomani del crollo del muro – questa messa a fuoco può muovere utilmente a mio avviso dal dialogo che, sul comunismo come idea e come esperienza storica, Ingrao svolge con Ferdinando Camon, scrittore di formazione cattolica, tra la fine del ’93 e il maggio del ’94. Nel corso di questo dialogo (e per l’esattezza: all’inizio e in conclusione di questo dialogo, in maniera perfettamente speculare) Ingrao sintetizza in due momenti e con grande efficacia cosa per lui (e direi anche per noi) può voler dire la parola “comunismo” avendo alle spalle il Novecento grande e terribile: la prima, per via del suo taglio critico-analitico, di impronta quasi hegeliana, è una definizione di tipo metodologico, che rinvia con la mente al passo marxiano sul “movimento che abolisce lo stato di cose presenti”. Dice Ingrao «il mio comunismo parte dalla critica a un tipo di società data, che è la società capitalistica, e tende a cercare come nel seno di questa società si producano delle contraddizioni per cui chi lavora si sente nemico a chi lo fa lavorare, e diventa il suo antagonista storico». Si tratta insomma di una visione del comunismo fortemente antidogmatica e antidottrinaria, perché non rinvia ad un corpus teorico, ad una strategia e ad un modello conchiuso, trascendente e autosufficiente, definito una volta per tutte e valido universalmente nello spazio e nel tempo. È, al contrario, la valorizzazione del comunismo come “punto di vista” (termine, questo, caro e fatto proprio da un altro grande di quella storia, della nostra storia, scomparso pochi mesi fa: Aldo Tortorella). Un punto di vista utile a scandagliare la realtà e ad individuare quelle contraddizioni sempre nuove che comprimono l’individuo e la sua libertà, che lo opprimono, che lo svuotano e che lo reificano, tanto nelle società capitalistiche, quanto – potenzialmente – anche nelle società di transizione che hanno cercato e cercheranno di costruire un altro mondo possibile. È questo l’approccio metodologico che permette ad Ingrao di tenere aperto l’orizzonte del comunismo anche dopo il fallimento della sua prima realizzazione storica; è su questo che basa il suo “cercare ancora” (avrebbe detto Claudio Napoleoni) le ragioni, le leve e le vie della trasformazione possibile.
La seconda definizione, quella che formula in chiusura del dialogo, ha invece un carattere prospettico, che rinvia quasi alla futurologia; ma ciò non perché Ingrao voglia formulare astrattamente delle ricette per l’osteria dell’avvenire, ma perché intende tracciare delle direttrici e indicare gli ambiti imprescindibili entro cui un comunismo rinnovato e reinventato è chiamato a dispiegare la sua attività critico-trasformativa. Dice: «E certo domani si tratterà di affrontare problemi che il comunismo classico non ha nemmeno sfiorato: inventare per l’umanità una vita che non sia tutta ridotta al momento lavorativo. […]. Il comunismo di ieri era tutto “fare”, tutto “lavoro”. Il comunismo di domani dovrà essere anche meditazione e contemplazione, dovrà affrontare le nuove contraddizioni. Al comunismo economico seguirà insomma un comunismo vitale. Dovrà essere un comunismo romantico, psicologico, sentimentale, che recupererà anche proposte dell’età pre-industriale, senza ripetere le condizioni sottoumane della vita contadina. È il traguardo della nuova politica, della nuova letteratura, della nuova arte: ed è un traguardo assolutamente irrinunciabile. Perché un mondo che non liquidi questi problemi è un mondo di una tristezza infinita».
Sono riflessioni, queste, che spiegano bene il motivo per cui, nell’articolo scritto con David e pubblicato a settembre su Micromega, abbiamo parlato a proposito di Ingrao dell’obiettivo di una “emancipazione umana integrale” e “multidimensionale”. Ingrao è forse, tra i dirigenti comunisti, quello che riesce a interpretare meglio, ad assumere nella maniera più conseguente e rigorosa, la svolta post-materialistica e post-acquisitiva annunciata dal ’68, con la sua attenzione alla dimensione qualitativa non semplicemente dello sviluppo, ma della stessa vita, una vita di cui i nuovi bisogni e le nuove domande emerse dagli anni Settanta in poi interrogano il senso ultimo. È in questa ambizione che risiede il significato del suo “volere la luna”. Già all’inizio degli anni Ottanta, con la formula dei “nuovi beni”, pone la necessità di delineare un arco di fini più ampio e variegato di quello ereditato dalla tradizione, al fine di arricchire e rinnovare «la scala di valori che il socialismo punta ad affermare», fuori dalle secche dell’economicismo e dalla statolatria. Ma nonostante questo bisogno, nonostante la necessità di questo salto di qualità nella tensione progettuale venga esplicitata nella forma più compiuta all’inizio degli anni Ottanta – quando cioè i pilastri del compromesso keynesiano postbellico sono ormai logori e si riconosce la necessità di esplorare vie che vadano “oltre lo Stato sociale”, come titola uno dei libri più importanti di Pietro Barcellona, tra gli intellettuali più vicini ad Ingrao –, l’attenzione di Ingrao e di quello che Luciana Castellina ha definito “l’ingraismo” come sensibilità politica larga e profonda, si manifesta già negli anni Sessanta. Nel pieno, cioè, del boom economico e di quella battaglia politica che nel Pci attraversa il gruppo dirigente post-togliattiano, snodandosi tra il convegno del Gramsci del ’62 sulle tendenze del capitalismo italiano e l’XI congresso del ’66, il primo senza Togliatti. Contrapponendosi infatti all’ala amendoliana, che dalla lettura stagnazionista del capitalismo italiano fa derivare la proposta (concreta ma minimalista) della politica dei mille rivoli, un pragmatico “riformismo a spizzichi” interessato a razionalizzare il capitalismo in senso antimonopolistico e a rispondere a bisogni quantificabili e monetizzabili (i “soldoni” di cui parlerà Amendola alla Conferenza operaia di Genova, nel ‘65), l’ala ingraiana traduce politicamente la sua diagnosi di un capitalismo dinamico e in via di modernizzazione con la parola d’ordine del “modello di sviluppo alternativo”. Ovvero, una visione delle “riforme di struttura” desiderosa di prendere questa categoria fin «troppo sul serio» (come affermerà ex post Lucio Magri, nel sarto di Ulm) e proprio per questo orientata a caratterizzarsi per la globalità e l’organicità di obiettivi tenuti assieme da una rigorosa geometria, da una rigorosa coerenza interna. E, in virtù di ciò, capaci di esprimere logiche e principi regolativi radicalmente difformi e antagonisti rispetto all’esistente. Nei fatti, e con almeno un decennio di anticipo rispetto ai teorici della silent revolution e del tornante post-materialistico, l’ala ingraiana del Pci, già nella prima metà degli anni Sessanta colloca in maniera pionieristica e straordinariamente preveggente la propria iniziativa su questo terreno, facendo ruotare la contesa strategica con la destra amendoliana attorno al nodo dello sviluppo e dell’alternativa tra la sua dimensione meramente quantitativa ed una sua declinazione più riccamente qualitativa.
E la discussione sulla valorizzazione della dimensione qualitativa della crescita che dopo il Rapporto del Club di Roma si impone a tutta la sinistra europea, sia comunista che socialdemocratica, viene declinata da Ingrao – proprio in ragione di questa sensibilità originaria, di questa propensione strutturale –non relegando il tema di politiche e strategie coerenti con quest’obiettivo alla sfera dei buoni sentimenti e al wishful thinking: per aggredire alla radice questo nodo, Ingrao esplicita nella maniera più conseguente il suo bilancio intelligentemente critico dell’esperienza novecentesca del movimento operaio, quel bilancio che rappresenta il minimo comune denominatore delle diverse anime riunite durante gli anni Sessanta sotto l’ombrello dell’ingraismo (per citare le tre diramazioni a mio avviso più importanti: Lucio Magri, Rossana Rossanda, Bruno Trentin). Un bilancio critico che rappresenta la base di tutta la ricerca che il Pci dell’epoca svolge sulla terza via, su una via capace di superare in avanti i limiti del modello sovietico e di quello socialdemocratico. Al fine di affrontare proficuamente la questione di una crescita qualitativamente orientata, per Ingrao vanno presi di petto e senza dogmatismi i due grandi nodi politici e teorici della sinistra e del movimento operaio: il nodo della proprietà e il nodo dello Stato. E quindi: il tema delle forme con cui realizzare l’obiettivo di un’appropriazione collettiva del lavoro sociale, di una funzionalizzazione delle attività economiche a finalità ed obiettivi altri rispetto al profitto individuale e all’accumulazione privata; ma anche il tema delle forme con cui socializzare il potere, con cui sanare lo iato e la scissione tra governanti e governanti, per avvicinare popolo e istituzioni, per congiungere “masse e potere”. La questione, dunque, di una democrazia piena e conseguente, restando distante tanto da illusioni assembleariste e direttiste – in cui vede il germe di degenerazioni corporative, particolariste e plebiscitarie – ma al tempo stesso estremamente determinato ad arricchire ed articolare la dimensione rappresentativa della democrazia, pena lo svuotamento stesso della rappresentanza, come teorizzato dal rapporto della Trilateral: insomma, la proposta di quella democrazia organizzata di massa che a metà degli anni Settanta contrappone al formalismo liberale di Bobbio e che tenta di dare una risposta alla stagione del sindacato dei consigli e al fiorire di forme ed esperienze di democrazia di base. Sta qui la ragione del suo interesse per ciò che si muove nel revisionismo di sinistra che attraversa le più importanti esperienze della socialdemocrazia europea, a partire da quella svedese e dal suo piano Meidner, Ponendo infatti il tema di una proprietà realmente sociale dei mezzi di produzione, il progetto dei socialdemocratici svedesi non solo rappresenta un sostanziale superamento delle politiche socialdemocratiche in senso stretto. Ma, prospettando forme di intervento e di “governo sociale” dei processi di accumulazione, definisce un nuovo quadro di compatibilità fra politica ed economia, un quadro alternativo a quello tipico compromesso keynesiano, e proprio per questo capace di avanzare una risposta politicamente e teoricamente forte tanto alla crisi dello statalismo proprietario dei paesi dell’est, quanto allo statalismo redistributivo tipico delle socialdemocrazie.
Si tratta dunque di una via, di un’ipotesi di riforme di struttura e di trasformazione sociale che rifiuta l’idea – rivelatasi terribilmente naif e infondata – che identifica la crescita del controllo sociale e democratico del lavoro vivo nella estensione meccanica della proprietà statale. Ingrao guarda inoltre con un interesse frammisto ad ammirazione al fatto che la costruzione di nuove forme democratiche nella sfera economica venga in qualche modo vincolata al ruolo produttivo dei soggetti sociali, scommettendo cioè sull’imprenditorialità collettiva espressa dai lavoratori associati all’interno degli organi di gestione dei fondi nel promuovere quella crescita e quella produttività sociale che, nell’epoca della disoccupazione tecnologica e della crescente divaricazione fra crescita ed occupazione, i capitalisti non sono più in grado di garantire. Ma l’interesse di Ingrao per i “fondi” del piano Meidner risiede soprattutto nel fatto che essi incrociano due assilli della sua riflessione di quegli anni. In primis, i meccanismi attraverso cui raccordare democrazia politica e democrazia sociale; secondariamente, il tema della “separazione dei produttori dai mezzi di produzione”: tornare a porre in maniera inedita rispetto alle realizzazioni del cinquantennio precedente la questione dell’assetto proprietario è per Ingrao una scelta assolutamente coraggiosa, specie nel momento in cui la fortuna del thatcherismo e del reaganismo si gioca tutta sul nodo della ri-privatizzazione di beni e funzioni sociali in precedenza strappate al mercato.
Anche qui: Ingrao non guarda al piano Meidner perché esso rappresenti un modello e ad una via già definita e pronta all’uso, ma perché costituisce un fecondo campo di ricerca e di sperimentazione, in grado di stimolare riflessioni in linea con le questioni enunciate. I nodi ancora aperti per la definizione di quello che come abbiamo definirà il comunismo vitale, non economicistico e non statalistico (aggiungo io: rosso-verde) sono ancora diversi, e vanno per lei tutti affrontati: innanzitutto, quello delle modalità con cui le forme di autogestione produttiva possono conciliarsi con la sfera delle politiche statali di redistribuzione e di investimento (combinazione senza cui nessuna strategia di trasformazione capace di incidere sulle decisione produttive fondamentali può darsi). In secondo luogo, quello delle forme con cui fornire un’adeguata rappresentanza ed espressione nelle sedi politiche e decisionali a quei bisogni qualitativi e post-acquisitivi che rimandano a fini generali e a scale di valori non quantificabili e per questa ragione irriducibili alla logica compensativa implicita nello schema dello “scambio politico”. E ancora, la questione dei criteri tramite cui affrontare la contraddizione potenzialmente esplosiva fra la logica che innerva le nuove forme di proprietà sociale collettiva, e quella, puramente quantitativa, che presiede invece a quei criteri di economicità tradizionali a cui continuano ad essere ancorate le singole imprese. Degli interrogativi che rinviano ad una questione cruciale e imprescindibile ai fini di una strategia di trasformazione sociale: quello delle modalità attraverso cui gestire la coesistenza conflittuale tra una razionalità a livello del sistema delle imprese e la razionalità a livello sociale. Il problema di fondo, per Ingrao resta insomma quello per cui una coerente azione di democratizzazione dell’economia e delle sue strutture obbliga a rimettere in discussione le stesse nozioni di produttività e di crescita economica, inevitabilmente deformate in senso quantitativo dalla logica capitalista.
Da qui la formula e l’idea di forma-politica a cui perverrà e rivendicherà per più di un decennio: quello di uno “Stato che aiuta a fare”, che non ricada cioè né nell’idea di un’iperstatalismo soffocante e oppressivo, né nella prassi socialdemocratica di un intervento a valle, subalterno e di tipo compensativo. Pensa insomma ad una forma statuale e democratica in grado di programmare tracciando grandi direttrici di sviluppo, che usi cioè le proprie leve per scardinare la pura logica di mercato, e che, al tempo stesso, non prenda tutto in mano verticisticamente, ma che sia al contrario impegnato a promuovere dinamiche di autodeterminazione, e quindi: luoghi, spazi e forme di autogestione e di autogoverno. È nella duttilità di questa forma democratica, nel suo saper stare tra la Scilla dello stalinismo e la Cariddi del compatibilismo minimalista, nel saper declinare in maniera innovativa l’ideale della riappropriazione sociale di funzioni politiche e di ricchezza prodotta, che risiede la chiave del suo “comunismo vitale”, un comunismo che proprio perché lotta contro tutte le forme di alienazione e reificazione, proprio perché si interroga sulla qualità e sul senso ultimo della vita, è in grado di confrontarsi appieno con la dimensione dell’alterità: tanto quella alterità rappresentata dal femminile e dalla sua insopprimibile differenza, quanto l’alterità che ha il suo centro nell’ambiente, in quello che definirà il “vivente non umano”.
fonte foto: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/93/Sei_dirigenti_del_Pci_nel_1965.jpg?uselang=it