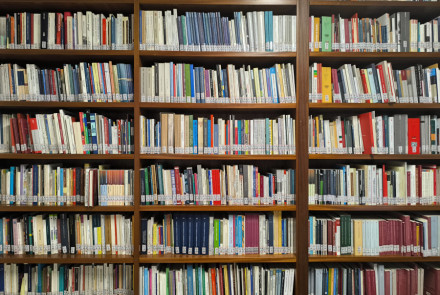LUCI SUL LAVORO NELLA POSTMODERNITà, CGIL TOSCANA E FDV APRONO IL CONFRONTO
Segnaliamo l'articolo di Pino Salerno, originariamente pubblicato sulla versione cartacea del quotidiano L'Unità, dal titolo " Senza dignità non c'è democrazia. Rifondiamo il lavoro" il giorno 10 luglio 2025. L'articolo racconta l'iniziativa organizzata dalla FDV insieme alla CGIL Toscana nell'ambito del festival "Luci sul lavoro", che si svolge a Montepulciano, oggi alla sua sedicesima edizione. Il dibattito, dal titolo "Il lavoro nella postdemocrazia", ha visto confrontarsi sul tema punti di vista accademici, sindacali e religiosi. Hanno partecipato: Don Bruno Bignami, Francesca Coin, Alessandro Volpi, Alessandra Ingrao e Michele De Palma. Saluti e introduzione di Rossano Rossi e Francesco Sinopoli, Presidente FDV.
QUI è possibile rivedere la registrazione dell'evento.
È accaduto a Montepulciano, nella splendida cornice della Fortezza Medicea, nell’ambito dell’annuale appuntamento di tre giorni dal titolo “Luci sul lavoro”. Non era semplice aprire il confronto sulla stringente attualità del rapporto tra il lavoro, il suo senso quasi smarrito e molto spesso povero, e le nuove condizioni dettate dalla crisi della democrazia liberale, che qualche anno fa furono previste dalle analisi di Colin Crouch, per il quale, appunto, siamo in quella fase della postmodernità in cui tante certezze del Novecento, comprese quelle sul lavoro come dignità ed elemento di socializzazione, rischiano di perdersi. E con esse rischiano di perdersi perfino forma e sostanza della nostra Costituzione. La sfida lanciata a Montepulciano dalla Cgil Toscana e dalla Fondazione Di Vittorio è di quelle che invitano, dunque, alla riflessione più attenta e a un’analisi assai più puntuale sulle trasformazioni in atto, culturali oltre che tecnologiche ed economiche. E va colta e rilanciata.
Come ha affermato il presidente della Fondazione Di Vittorio, Francesco Sinopoli, nella sua introduzione al convegno, “ci troviamo dinanzi a cambiamenti profondi e inediti, che oggi sfuggono alla gran parte delle persone, anche se alcuni intellettuali, come Colin Crouch, e prima di lui negli anni Novanta, Christopher Lasch, avevano già definito gli elementi sostanziali della crisi della democrazia liberale. Tuttavia, nessuno di noi avrebbe potuto immaginare a quale grado di regressione potesse giungere la crisi della democrazia nei Paesi a capitalismo avanzato”. Sinopoli ha poi proseguito citando le illuminanti parole di Bruno Trentin pronunciate fin dagli anni Settanta in un convegno sulla crisi delle democrazie socialiste sovietiche: “la democrazia avanza nel mondo grazie al movimento operaio, con le sue lotte, e perfino le istituzioni, come le intendiamo oggi, recano le impronte delle lotte sociali”. La relazione stretta, pertanto, tra la forma e la sostanza della democrazia con le conquiste del movimento di lavoratrici e lavoratori, per Sinopoli, erano già presenti nelle analisi di intellettuali e leader sindacali del Novecento. Perché allora parlarne oggi, e perché su questa scia storica rilanciare la sfida? Sinopoli è molto netto: “il fatto che i teorici della democrazia ad un certo punto abbiano rinunciato ad analizzare il suo rapporto col lavoro, considerandolo non più necessario, è per noi la questione centrale del XXI secolo, soprattutto perché la Costituzione è fondata sul lavoro, asse portante del movimento di lavoratrici e lavoratori ed è frutto delle loro lotte”. Dove risiede dunque il collasso della democrazia liberale, iniziata fin dagli anni Settanta, con il processo di ristrutturazione capitalistica e la sua conseguente finanziarizzazione che sacrifica produzione e lavoro, e quali effetti sta provocando sul Ventunesimo secolo? “Ecco perché lanciamo questa sfida epocale, per il movimento sindacale e non solo, di costruire analisi del presente”, ha poi concluso Sinopoli, sottolineando la necessità di capire le aporie del rapporto tra conflitto e partecipazione, sempre più in difficoltà nell’epoca della postdemocrazia.
Don Bruno Bignami, direttore dell’Ufficio nazionale per i problemi sociali e del lavoro della Conferenza episcopale italiana, ha accettato la sfida lanciata da Cgil Toscana e Fondazione Di Vittorio restituendo le analisi di papa Francesco sui temi del lavoro e della democrazia (e della postdemocrazia). “Segnalo tre passaggi nel magistero di papa Francesco che richiamano la nostra attenzione sui temi del lavoro, con una premessa: il magistero di papa Francesco è più che mai vivo proprio perché ci ha insegnato ad attivare processi più che a occupare spazi, e dunque ha attivato dei processi, tra cui anche quella iniziativa chiamata Economy of Francesco, mossa soprattutto da tanti giovani. Essa è un movimento che si occupa di riflettere su una economia differente. Non è solo un magistero di cose dette, ma di investimenti in persone che non si ritrovano in un modello economico che continuamente genera scarti e che invece ha bisogno di valorizzare le persone”. Per don Bruno Bignami, “intanto, quella di papa Francesco è una teologia del lavoro, che già nel Novecento ha prodotto passi interessanti, fondata non solo sull’opera creatrice di Dio, cosa abbastanza evidente e ovvia, quanto nell’opera di Gesù Cristo. Cosa vuol dire? Vuol dire che al centro ci sta Gesù Cristo lavoratore, concetto sul quale riflettiamo troppo poco. Nello stesso Vangelo di Marco, Gesù è definito non come il figlio del falegname ma come il falegname, ovvero come colui che svolge un lavoro complesso e di precisione. Gesù per trent’anni fa questo, e poi per tre anni gira a predicare. Papa Francesco connota questa specificità di Gesù come colui che vede nella materia inerte l’opera creatrice dell’uomo, l’artigiano che dal pezzo di legno trae un violino, ad esempio”. Cosa significa questo cambio di paradigma teologico? Don Bignami è molto netto, anche dal punto di vista antropologico: “noi non siamo solo carne umana, ma progetti. La teologia del lavoro di papa Francesco è dunque questa capacità del Dio artigiano di vedere dentro le nostre esistenze una straordinaria capacità espressiva. Ognuno di noi attraverso la sua intelligenza e il suo lavoro è capace di grandi cose”. A questo punto, don Bignami sottolinea il carattere antropologico della teologia del lavoro di papa Francesco citando i due documenti forse più famosi del suo magistero, Laudato sì’ e Fratelli tutti: “il lavoro è la grande questione sociale, perché il lavoro non solo permette alle persone di vivere ma ha tutta un’altra serie di relazioni con la dignità. Nel lavoro la persona impegna se stessa, apprende la vita con gli altri, acquisisce saperi e competenze, vive un’esperienza comunitaria. Il lavoro è il mondo in cui ci si relazione col mondo, la Laudato sì’ ha questa visione molto audace che muta i paradigmi sul tema del lavoro, perché il lavoro migliora il mondo, costruisce un mondo diverso. Dunque, per papa Francesco non è lavoro ciò che distrugge il mondo. Ciò che distrugge l’umanità, costruire bombe o mine antiuomo è lavoro? No, dice papa Francesco. È attività umana ma non è lavoro. Ecco perché dovremmo essere più rigorosi quando pensiamo a ciò che è il lavoro. Il lavoro migliora la comunità e la vita degli uomini? O è semplicemente un’attività che permette a un’economia di muovere il Pil e quant’altro e non conta niente rispetto a ciò che realizza e alla qualità di una società? Ecco perché se seguiamo papa Francesco nella sua riflessione antropologica e teologica, dovremmo avvertire quelle aziende che decidono di riconvertire la produzione in armamenti che quello non è futuro”. Don Bruno Bignami rammenta poi più volte l’intervento di papa Francesco nel corso dell’incontro con la Cgil in Vaticano. Insomma, c’è un’attenzione specifica di papa Francesco legata ai problemi concreti del mondo del lavoro. Don Bignami segnala tre passaggi: “il tema drammatico della sicurezza sul lavoro, un vero e proprio bollettino di guerra per il papa; il valore centrale del lavoro è la persona; e la definizione di un neologismo, il carewashing, ovvero l’investimento degli imprenditori in calciatori piuttosto che in costosi oggetti artistici e altro, per agevolare un ritorno d’immagine, piuttosto che investire sulla sicurezza sul lavoro. Il carewashing di cui parla papa Francesco è l’artificiale costruzione della propria immagine a discapito della sicurezza e del valore del lavoratore. Su questo tema, interviene più volte”. Don Bignami ricorda anche l’attenzione massima rivolta da papa Francesco ai temi dell’ingiustizia e dello sfruttamento, che colpiscono soprattutto donne e giovani. E infine la sensibilità di papa Francesco sulla questione del lavoro povero, e degli scarti umani, del nuovo schiavismo e dello sfruttamento, delle condizioni disumane che schiacciano le persone, e il profitto diventa l’unico criterio con cui viene analizzato il lavoro. “Cosa rimane dunque di questo magistero e cosa resta fondamentale?”, si chiede don Bignami. Intanto, provare a immaginare forme differenti di economia, del tipo dei movimenti popolari, ovvero i lavoratori che si auto-organizzano rispetto a un’economia ingiusta, quelli che non si sono mai rassegnati, e immaginano nuovi percorsi di riconquista della dignità del lavoro, recuperando la persona. Nel magistero di papa Francesco c’è tanto da recuperare, dunque, ed è un’impresa assai utile ed efficace anche per la sfida che la Cgil e la Fondazione Di Vittorio lanciano.
Per Francesca Coin, sociologa dell’Università di Parma, “oggi va ripensato il tema della classe, e dobbiamo capire, anche in relazione al referendum dell’8 e 9 giugno scorso, cos’è la classe, e dove sta la classe. Intanto penso che quel referendum sia stato giusto promuoverlo perché si attaglia perfettamente all’epoca storica che stiamo vivendo, di grandi solitudini e di grande isolamento anche nei luoghi di lavoro. La fotografia che ci è offerta dal Rapporto Istat ci parla di un Paese attraversato da grandi crisi industriali, da lavoro povero e da una crescente quantità di giovani e donne che espatriano. Abbiamo un mercato del lavoro in profonda crisi, e tuttavia la rappresentazione che ci viene data è del tutto opposta”. Che tipo di crisi viviamo, si chiede Francesca Coin. “Si tratta di una crisi di Paese, di una crisi del modello di sviluppo, perché non c’è alcuna visione. Ma la crisi più grande, evidente e più drammatica, è la crisi delle persone, e pensavo che col referendum soprattutto chi vive il disagio avrebbe risposto con maggiore partecipazione e passione. Così non è stato, e dobbiamo capirne le ragioni. Solitudine, depressione, desolazione sono divenuti fenomeni di una portata quantitativa mai vissuta prima. Desolazione: parola importante, usata da Hannah Arendt proprio ne Le origini del totalitarismo, ci racconta dell’erosione della solidarietà tra persone, tra chi lavora, tra chi vive nelle comunità, grandi e piccole”. La desolazione e l’assenza di solidarietà, nell’analisi di Francesca Coin, sono fenomeni che originano in parte l’antidemocrazia, la mancata partecipazione, l’assenza dalla vita pubblica e sociale. È una condizione, come affermava Hannah Arendt, che permette al potere una facile manipolazione. “Abbiamo superato la postdemocrazia e stiamo scivolando verso l’antidemocrazia”, è l’amara conclusione di Francesca Coin. Anche se dal risultato referendario, afferma ancora la sociologa, qualche elemento positivo per cambiare la rotta ancora esiste. Occorre partire da lì. “Occorre recuperare il senso di una campagna culturale di emancipazione sociale, soprattutto per contrastare il vento antidemocratico che spira dagli Stati Uniti di Trump, e che ci racconta di una società naturalmente diseguale”.
Alessandro Volpi, docente di Storia contemporanea presso l’Università di Pisa, ha poi dimostrato con l’uso di diverse slide come si sta muovendo il capitalismo finanziario italiano, quali connessioni con il mercato azionario globale, quali investimenti improduttivi e soprattutto quali scelte ne accompagnano i profitti per gli azionisti. Una carrellata, forse inedita per i più, con storie, vicende, nomi e cognomi di un’economia finanziaria che smette di produrre merci e investe nella carta moneta, in quella economia dove “carta produce carta”, e in cui il profitto si conta in decine e decine di miliardi.
A sua volta, Alessandra Ingrao, associata di Diritto del lavoro presso l’Università di Milano, ha costruito le straordinarie connessioni nella Costituzione italiana tra i diversi articoli che parlano di lavoro e democrazia, a partire da quel fondamentale comma 2 dell’articolo 3. Alessandra Ingrao recupera in particolare quell’articolazione in cui si scrive che compito dello Stato è rimuovere gli ostacoli che impediscono “l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. Si tratta dell’unica volta, sostiene Ingrao, in cui la Costituzione cita esplicitamente i lavoratori, e lo fa nella connessione con il principio democratico della partecipazione, come se, appunto, senza i lavoratori non vi fosse autentica democrazia. “L’articolo 3 pone la questione delle società industriali complesse”, ricorda Ingrao, nelle quali attraverso le forme della rappresentanza sindacale “si modera, si tempera il potere dell’imprenditore”. Ma nella Costituzione, negli articoli 36 e 49, è presente la convinzione che rappresentanza, contrattazione collettiva e conflitto sono indissolubilmente legati. Tuttavia, il legislatore ha deciso nel corso degli anni di non dare seguito a queste norme costituzionali. Ne è ultima testimonianza il modo in cui il Parlamento a maggioranza di centrodestra ha utilizzato, cambiandola profondamente, la legge di iniziativa popolare della Cisl sulla partecipazione dei lavoratori nelle aziende. Non era certo questa l’intenzionalità con la quale i padri costituenti hanno immaginato il secondo comma dell’articolo 3.
“Il lavoro crea, la guerra distrugge, questo è il tempo nel quale viviamo”, dice nella sua conclusione Michele De Palma, segretario generale della Fiom. Nell’analisi conclusiva di De Palma emerge soprattutto la questione della sconfitta del movimento dei lavoratori nell’ultimo mezzo secolo. “Si tratta di una traccia analitica con cui dobbiamo fare rigorosamente i conti, se vogliamo uscire dalla crisi politica del mondo del lavoro”, sostiene De Palma. La crisi non fa riferimento solo al fatto della mancata partecipazione elettorale. “Cos’è la democrazia se non quella straordinaria capacità di equilibrare i poteri, tra coloro che lo detengono e coloro che invece ne sono sprovvisti? Si partecipa alla vita democratica quando si è consapevoli che con la partecipazione si dà senso a quell’equilibrio. Lo svuotamento democratico risiede innanzitutto nella convinzione contraria, secondo cui nessuno privato dei poteri può riequilibrare il sistema. Ma nemmeno i capitalisti oggi sono tranquilli, se guardiamo alla democrazia in America. Il punto della democrazia non è semplicemente nel calcolo quantitativo di quante persone partecipano alle elezioni, ma nella condizione materiale di perdita e di smarrimento del lavoro. Ecco perché occorre chiedersi cosa è stata la sconfitta, a partire dalla verticale separazione tra il lavoro e ciò che produce rendita, tra i capitalisti e la conoscenza dei sistemi di produzione materiale”. Per De Palma torna la grande questione della presenza pubblica, dello Stato, nella produzione, come accade in alcuni grandi Paesi europei, non solo per cercare di battere la crisi, ma soprattutto per restituire un orientamento di senso. Anche per questa ragione, per De Palma, “il conflitto oggi non solo è una scelta, ma è soprattutto una necessità, perché quel patto tra capitale e lavoro oggi è stato divelto. Il capitale quella storia non riesce più a raccontarla. Per questo si restringono gli spazi di democrazia, ma finito il tempo della resistenza giunge ormai il tempo della liberazione”.