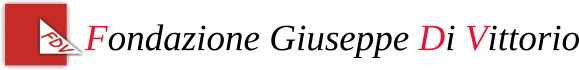UN OMAGGIO A BRUNO TRENTIN: INTELLETTUALE, MILITANTE, SINDACALISTA
Il 22 agosto del 2007 si è spento a Roma Bruno Trentin, storico dirigente del movimento sindacale italiano e internazionale, nelle cui fila aveva cominciato a militare sin da giovanissimo, durante gli anni dell’apprendistato anti-fascista, trascorsi nell’esilio francese, in cui si era rifugiata la sua famiglia, e dove era nato – a Pavie – nel 1926. Da un anno ormai viveva in condizioni estremamente critiche, da quando l’estate prima – sui sentieri delle sua amatissime Dolomiti – era incorso in un brutto incidente con la bicicletta e dal quale non si era più del tutto ripreso. Con lui se ne va una delle figure più autorevoli e affascinanti del sindacalismo europeo; un protagonista assoluto del suo tempo e leader di tante battaglie del movimento operaio, non soltanto italiano.
Figlio di Silvio Trentin, professore universitario e militante politico di ispirazione radical-democratica, Bruno entra a far parte della resistenza francese, nelle file del movimento giovanile del “Groupe insurrectionel francais”, passando poi col padre all’organizzazione partigiana di “Giustizia e Libertà”, una formazione nella quale – in quegli anni – aderiscono alcuni grandi esponenti italiani del pensiero democratico, socialista e libertario, fra cui Emilio Lussu, Piero Gobetti e Norberto Bobbio. Alla fine della guerra completa i suoi studi in giurisprudenza e si laurea ad Harvard. Decide però che il suo posto dev’essere a fianco degli sfruttati; si iscrive al PCI ed entra nell’ufficio studi della CGIL, dal quale collabora all’elaborazione della strategia sindacale di Giuseppe Di Vittorio, il carismatico bracciante pugliese, di cui sarà discepolo e giovane braccio destro. Diversi per estrazione sociale, età e temperamento, Trentin e Di Vittorio condividono una comune ascendenza anarchica – coltivata negli anni giovanili – che li renderà dirigenti irrequieti ed eretici nelle fila del comunismo sindacale e politico, di cui saranno comunque protagonisti indiscussi. A loro si deve il profilo teorico e programmatico di un sindacato come quello della CGIL, imperniato sui valori dell’autonomia, della confederalità, della democrazia sindacale, dei diritti e della solidarietà, contro i rischi di subalternità politica, di deriva corporativa della rappresentanza, di chiusura settaria all’innovazione. Una trama di orientamenti e principi riconducibile, nel caso di Trentin, al suo duplice rigetto delle ideologie produttiviste e stataliste della tradizione sia socialdemocratica che comunista del movimento operaio internazionale, con una attenzione primaria rivolta piuttosto ai temi dell’organizzazione del lavoro e del controllo operaio. Un autentico fil rouge, che attraversa e tiene unite le tappe più preziose e innovative del suo percorso culturale e politico-sindacale: il sindacato dei Consigli e il suo modello di rappresentanza, la centralità del rapporto fra saperi e poteri e dunque – sul versante contrattuale – il carattere cruciale del nesso formazione continua e democrazia industriale.
Trentin ha rappresentato una figura paradigmatica di “intellettuale organico”, in grado di cimentarsi con l’esegesi più complessa del marxismo e delle sue svariate correnti storico-dottrinarie, ma anche con la sociologia del lavoro americana e francese, sin dai suoi studi sul neo-capitalismo, agli inizi degli anni ’60. Nei suoi numerosi contributi teorici ricorre costantemente la critica dell’egemonia ideologica del fordismo nella cultura socialista e comunista, e del leninismo in particolare, anche nella sua variante gramsciana. Scrive: “Lenin non ha mai guardato alle lotte sociali per mutare l’assetto organizzativo e gerarchico delle grandi imprese come al possibile elemento motore di una partecipazione reale della classe operaia alla direzione della “sua” società. Il partito si sostituisce alla classe e ne interpreta gli interessi”. Da questo punto di vista Gramsci rivela una concezione indubbiamente più articolata del rapporto fra partito e classe, fra politica e società civile, ma Trentin non gli risparmia le sue critiche per la celebrazione che in “Americanismo e fordismo” viene rivolta al taylorismo. Un apparato presuntivamente neutro, la cui natura sociale può mutare di segno solo se la classe operaia assume la direzione dello stato. Per Gramsci la grande fabbrica costituisce un insieme razionale e funzionale, laddove è la sfera della distribuzione capitalistica ad essere irrazionale e anarchica. Per Trentin Gramsci, al pari delle correnti maggioritarie del movimento operaio internazionale, non viene mai sfiorato dal dubbio di una diversa divisione tecnica del lavoro. Egli rivela “un distacco totale dalle trasformazioni della classe operaia reale e dalle drammatiche contraddizioni che la attraversano”. Non basta neppure, nelle pagine dell’”Ordine Nuovo”, evocare il Consiglio dei delegati come governo autonomo della fabbrica; embrione e fondamento di un nuovo tipo di Stato. Per Trentin c’è un aspetto che né Gramsci, e meno che mai i dirigenti bolscevichi, colgono adeguatamente, ed è la resistenza dei lavoratori subordinati, sorda o manifesta che fosse, alla parcellizzazione dei lavori e delle funzioni. Basti pensare al dibattito in seno al partito bolscevico, durante il X Congresso, nel 1920, dove “l’opposizione operaia” di Sliapnikov viene del tutto emarginata dall’asse Lenin-Trockij-Bucharin, a sostegno della militarizzazione del lavoro e dalla statizzazione dei sindacati.
Per Trentin c’è sempre stata un’intelligenza operaia che si rifiuta di abdicare e che ha funzionato come elemento correttivo del sistema. Ed è su quella base di intelligenza, su quel correttivo sociale, che occorre fondare un modello diverso di società. Da qui la sua “utopia” di risoggetivizzare in chiave umanistica il senso e i contenuti del lavoro. Tutti i suoi scritti sono perennemente intrisi e ispirati da questa tensione ideale e politica. “Da sfruttati a produttori” fu il titolo di una sua importante raccolta di scritti e interventi, nel 1977. Negli anni ’80 studierà con grande attenzione le esperienze scandinave più avanzate in tema di organizzazione del lavoro, come gli stabilimenti della Volvo a Udevalla. Ad esse ispirerà il suo impegno sindacale a sostegno della codeterminazione.
Per Trentin il sindacato dev’essere un’organizzazione libera, volontaria ed autonoma. Autonoma innanzitutto dalle imprese; un postulato apparentemente elementare, che lo porterà a diffidare profondamente da quelle ideologie neo-capitaliste – fatte proprie dall’interclassismo della CISL negli anni ’50 – che attraverso forme ambigue e indistinte di partecipazione (comprese quella societaria o finanziaria), rischiano di offuscare il carattere irriducibilmente dialettico del rapporti di produzione.
Autonomia dallo Stato, che per Trentin si declina in un duplice senso. Innanzitutto attraverso il rigetto di qualunque privilegio istituzionale e finanziario da parte dell’apparato pubblico, e in base al quale chiederà – nella sue veste di Segretario Generale della Cgil – il ritiro di tutti i rappresentanti sindacali in seno ai Consigli di amministrazione degli enti pubblici; il rifiuto di qualunque coinvolgimento diretto nella gestione della formazione professionale; la diffidenza verso quei modelli di sindacato – come quelli scandinavi – dotati della prerogativa parastatale di amministrare i fondi contro la disoccupazione (sistema Ghent). Un sindacato, per essere autenticamente libero, dev’essere integralmente volontario, nel senso di salvaguardare sempre la libertà negativa di non essere iscritti. Da qui l’”orrore”, se così possiamo permetterci di definirlo, verso qualunque forma di “closed-shop” e gestione sindacale del collocamento, di cui la vicenda sindacale italiano porterà tracce in un solo caso: quello delle compagnie dei portuali, molto di sinistra, ma di cui Trentin sarà un fiero avversario. In secondo luogo, attraverso un contrasto teorico e politico nei riguardi del neo-corporativismo, ritenuto foriero di una sostanziale cooptazione dall’alto, nei confronti del sindacato, a discapito dell’autonomia e del consenso dal basso, con rischi di invasione di campo nella sfera della sovranità democratica delle istituzioni rappresentative. Scrive: “L’autorità dello Stato finisce per sostituire il consenso dei lavoratori coinvolti dal negoziato collettivo, sul quale il sindacato fondava in origine il proprio potere di iniziativa e contrattazione”.
Ciò non gli impedirà di sottoscrivere i protocolli tripartiti del 1992-93, con cui si è definito in Italia il quadro regolativo che disciplina – grazie a un atto non legislativo – la politica dei redditi, la contrattazione collettiva e la rappresentanza nei luoghi di lavoro. Trentin, l’artefice di quegli accordi, pagherà un prezzo alto, sia umano che politico, a quella scelta; con le dimissioni da Segretario, rigettate dal direttivo nazionale della CGIL, e le contestazioni durissime ricevute dalla piazza, a Firenze, nell’autunno del ’92. Lui, leader carismatico dei metalmeccanici e delle lotte operaie durante l’autunno caldo del ’69. Lui, esponente della sinistra interna al PCI, che fa capo a Pietro Ingrao, e da sempre vicino al collettivo de Il Manifesto. Il paese è in ginocchio, stretto nella tenaglia di una crisi economica e politica senza precedenti. Gli industriali hanno unilateralmente abrogato la “scala mobile”, il meccanismo che per anni aveva indicizzato automaticamente il potere d’acquisto dei salari. L’inflazione è a due cifre; la lira ha subito un pesantissima svalutazione e l’intero sistema politico è squassato dallo scandalo di mani pulite. Il sindacato deve fare la sua parte, attribuendosi una funzione politica che sia comunque compatibile con la sovranità delle istituzioni democratiche della rappresentanza generale. Trentin considererà gli accordi del 1992-93 come qualcosa di diverso dai tradizionali accordi di matrice neo-corporativa, verso i quali non ha mai nutrito alcuna particolare simpatia. La differenza, secondo lui, risiede nell’ampio grado di autonomia che il sindacato riesce in ogni caso a preservare, sin dentro ai meccanismi che governano d’ora in poi la politica dei redditi. Si consideri che il sistema italiano delle relazioni industriali rimane quello in assoluto meno giuridificato fra i paesi più avanzati. E che in pochi altri paesi il diritto di sciopero risulta così integralmente preservato da limitazioni legali in ordine ai fini e ai modi del suo svolgimento. Per lo meno nel settore privato. Ciò significa che nello scambio politico del ’93, l’autonomia e il conflitto non sono pregiudicati come in altri paesi – come la Svezia, l’Austria, la Germania – dove il riconoscimento legale di poteri, anche molto intensi, di co-determinazione sindacale delle politiche aziendali e pubbliche sono state pagate al prezzo di una severissima compressione del diritto di sciopero.
Vi e poi l’autonomia dai partiti. Il dato che forse più di ogni altro ha segnato “l’eresia” del sindacato social-comunista italiano, e di cui Trentin è stato fra i maggiori teorizzatori e interpreti. Contrariamente ad una tradizione che aveva accomunato tanto l’ortodossia comunista quanto quella socialdemocratica, e riassumibile nel nesso asimmetrico del sindacato “cinghia di trasmissione” del partito, Trentin – insieme a tutti i maggiori protagonisti della storia sindacale italiana dagli anni ’60 in poi – rigetta questo principio. Il primo passo, formale, è l’introduzione del regime di incompatibilità, ai livelli più alti, fra le cariche sindacali e quelle partitiche. Eletto in Parlamento nel 1963, Bruno Trentin fu il primo esponente sindacale comunista ad annunciare la rinuncia al suo seggio, due anni dopo. Un passo condiviso da tutte le organizzazioni metalmeccaniche, sin dal 1966, e successivamente – non senza resistenze – da tutta la CGIL, al Congresso di Livorno del 1969. Un elemento – quello della incompatibilità – destinato a distinguere la vicenda sindacale italiana da quella di molti sindacati europei, dove la presenza incrociata di cariche direttive fra quadri sindacali e partitici – è opportuno ricordarlo – permane tuttora e in modo il più delle volte incontroverso. L’ultimo passo di questo percorso si avrà agli inizi degli anni ’90, quando nelle vesti di Segretario Generale (post-)comunista della Cgil, Trentin scioglierà il vecchio sistema delle correnti di partito, con il quale – a partire dalla ricostituzione di un sindacato libero e unitario nel ’44 – si era consentita l’espressione organizzata, ma non distruttiva, del pluralismo politico dentro la Cgil: comunisti, socialisti e poi anche la “terza componente” legata alla nuova sinistra. Da allora in Cgil ci si confronta sul terreno esclusivo dei documenti programmatici e delle piattaforme congressuali; maggioranze e minoranze.
Per Trentin, come prima di lui per Di Vittorio e Lama, l’unità dei lavoratori andava considerata un valore assoluto, da perseguire nel vivo della condizione materiale di lavoro e di sfruttamento. Il superamento delle vecchie divisioni ideologiche e partitiche dei lavoratori deve sorgere dalle fabbriche e non dalla eventuale somma degli apparati burocratici. Qui si colloca una delle realizzazioni più innovative e determinanti del Trentin teorico e dirigente sindacale: i Consigli di fabbrica. Nati nel clima del “autunno caldo”, i Consigli devono rappresentare la struttura del nuovo sindacato unitario, di cui la Federazione dei Lavoratori Metalmeccanici (FLM) – che unisce le sigle di categoria di CGIL, CISL e UIL – sarà in quegli anni l’avanguardia. I delegati vengono eletti su lista bianca, da iscritti e non iscritti, e sono dotati di potere contrattuale, secondo uno schema di single channel diverso da quello inglese o svedese. Il Consiglio è un organismo “anfibio”: l’espressione di tutti i lavoratori, ma anche il momento di sintesi che il sindacato esprime in fabbrica. Il delegato di reparto è al contempo il rappresentante del gruppo omogeneo che lo ha eletto, ma è anche un dirigente e un militante con responsabilità nei riguardi dell’insieme dei lavoratori. E’ così che lo concepisce Trentin e così che in effetti diventa. Un’impostazione che rivela la grande conoscenza che Trentin possiede riguardo al dibattito europeo degli anni ’20 su questi temi (il Linkskommunismus di Korsch o Pannekoeck; di Gramsci e Tasca). La sua posizione è diversa da quella neo-gramsciana, ripresa dalla sinistra extra-parlamentare di allora, volta ad affermare un ruolo dei delegati interamente svincolato dal sindacato. L’approccio di Trentin mira a scongiurare una deriva autarchica e corporativistica dei Consigli, nella direzione di una unità di classe che si esprime attraverso una nuova articolazione di tutti i poteri democratici che è in grado di esercitare. Contro il sistema del doppio canale – comune a tanti paesi dell’Europa continentale – Trentin contrappone il carattere unitario della rappresentanza in Italia. Non vi è alcun motivo per scindere e duplicare la rappresentanza dei lavoratori, sia sotto il profilo del mandato e della legittimazione democratica, sia sotto quello funzionale, fra poteri (sindacali) di contrattazione collettiva e poteri (dei consigli) nel campo partecipativo dell’informazione e consultazione.
L’analisi di Trentin sull’autonomia sindacale si pone fuori dalla dicotomia tradizionale fra il politico ed il sociale. Le differenze fra il partito ed il sindacato devono poter essere ricondotte ad un “processo conoscitivo” e ad una strategia, che tendono a divergere in rapporto al tempo e allo spazio. Nel tempo, perché laddove il partito organizza obiettivi e tappe dell’azione sulla base di una visione della società e del mondo proiettata nel futuro, e quindi collegata ad un disegno complessivo di trasformazione, nel sindacato – la preminenza dell’essere “parte” ed “immediatezza” – non consente mai di partire da un disegno di mediazione, coerente ad un progetto di cui si dispone a priori. Nello spazio, in quanto il partito, per sua originaria configurazione, è portato a collocare i contenuti della sua azione rivendicativa in un contesto di mediazione più ampia, che abbraccia l’intera società.
Questo venir meno dei vecchi schemi di compartimentazione del lavoro politico nei partiti ed economico-sociale nei sindacati indurrà molti osservatori ad accusare l’azione posta in essere in quegli anni da CGIL, CISL e UIL di “pansindacalismo”. Negli anni ’70, quando in Italia il confronto ideologico a sinistra si fa particolarmente serrato, per non dire violento, Trentin si schiera contro “i profeti dell’autonomia del politico” e del primato della dimensione dello Stato come luogo della politica, in cui sfidare il grande capitale.
Fu difficile fare accettare al PCI e alla sua dirigenza questi principi. Ma la Cgil e il PCI si mostrarono in definitiva capaci di quella duttilità che mancherà invece ai cugini francesi della CGT e del PCF. Un dato che concorre a spiegare – a dispetto dei pur tanti punti comuni di partenza – le traiettorie diversissime assunte dalle organizzazioni di sinistra di questi due paesi latini.
La CGIL si rivela presto un osso duro per il sindacalismo di stretta osservanza moscovita: la Federazione Sindacale Mondiale (FSM). Trentin accompagnerà Di Vittorio, che dell’FSM è allora il Segretario Generale, al Congresso di Vienna del 1953. E con lui condividerà la durezza del contrasto coi sovietici e coi francesi intorno al concetto, caro e irrinunciabile per gli italiani, del sindacato “soggetto politico”. Come quando, con le parole di Di Vittorio, il sindacato “si mette alla testa” dei movimenti per la riforma agraria. Un approccio che raccoglierà grandi plausi da parte delle organizzazioni sindacali del Terzo Mondo, ma anche la più totale chiusura di russi e francesi, che in nessun modo possono accettare l’idea di un sindacato che “ruba” il mestiere al partito. Quel Congresso si conclude con l’umiliante anomalia di una relazione del Presidente, Di Vittorio, che non raccoglie l’approvazione dell’assemblea dei delegati.
E poi ci sarà il contrasto durissimo fra CGIL e PCI, fra Di Vittorio da un lato e Togliatti dall’altro, sulla valutazione intorno ai c.d. “fatti di Ungheria”, rispetto ai quali la posizione del sindacato social-comunista sarà di inedita durezza. Una scelta che oltre a porre la CGIL dalla parte della ragione, e non del torto, consente a questo sindacato di non pagare il prezzo di scissioni o abbandoni che colpiranno invece il PCI a causa di quella posizione errata.
Fra i suoi impegni internazionali più recenti e riusciti, il sostegno a fianco del sindacato brasiliano della CUT e di quello sudafricano del COSATU.
Vi sono vari aspetti che segnano peculiarmente la natura e il ruolo del sindacato italiano nell’ambito della comparazione internazionale fra modelli. Uno di questi è certamente costituito dal primato confederale su quello settoriale, e ancor più su quello di mestiere, di fatto abrogato sin dal 1900; quando la FIOM si costituisce e diventa uno dei primi sindacati industriali della storia moderna. A dispetto dell’arretramento, assoluto e relativo, in cui versa l’economia e lo Stato italiano.
Una confederalità che si configura attraverso un’ispirazione massimamente inclusiva della rappresentanza associativa e negoziale, aperta a tutti – senza distinzione di settore, livello professionale, grado di istruzione. A questo riguardo si deve a Trentin la riforma del pubblico impiego, del 1993, con la quale il rapporto di lavoro pubblico viene interamente contrattualizzato, ponendo fine ai vecchi regimi di diritto pubblico che artificiosamente dividevano lavoro privato da lavoro pubblico.
Il rischio, per Trentin, è che il sindacato si arrocchi nella difesa dei gruppi più garantiti, con posizioni di tipo corporativo. Negli ultimi anni sarà una preoccupazione costante: rappresentare tutto il mondo del lavoro e non soltanto una parte di esso. Del resto annoterà come la classe lavoratrice reale non è più riducibile alla classe operaia, per altro sempre più articolata nelle sue condizioni di vita e di libertà.
Come Segretario Generale della CGIL, nel 1991, lancerà il concetto si sindacato dei diritti e della cittadinanza. L’idea di fondo è che la possibilità di ricostruire una visione unitaria e nuove forme di solidarietà in un mondo del lavoro che si diversifica, passa attraverso il riconoscimento esplicito delle differenze, dei bisogni individuali e collettivi dei diversi soggetti, contro le spinte pur presenti verso sbocchi di tipo corporativo. Nel documento congressuale, direttamente ispirato da Trentin, si legge: “Il riconoscimento delle differenze, la coscienza delle contraddizioni che sono aperte nel mondo del lavoro, l'abbandono di ogni visione mitica e ideologica dell'unità di classe, tutto ciò implica da un lato l'elaborazione di politiche rivendicative differenziate e flessibili e di politiche organizzative che siano modellate sulla realtà e capaci di rappresentare le differenze, e dall'altro l'assunzione di pratiche democratiche trasparenti che consentano di reimpostare tutto il rapporto fra sindacato e lavoratori, superando le varie forme di burocratizzazione e di dirigismo autoritario”.
Negli ultimi anni del suo impegno, come intellettuale e come esponente politico del Partito Democratico di Sinistra, il suo slancio maggiore tornerà a riguardare i suoi temi di sempre: i saperi e la conoscenza, da assumersi – attraverso la formazione – come condizione ineludibile per l’affermazione reale dei poteri e della cittadinanza sociale dei lavoratori.
Il sindacato deve sapersi porre all’altezza di questa sfida. Deve sapere studiare innanzitutto la società e i suoi cambiamenti, per poterli condizionare e orientare. Non è un caso se, alla fine degli anni ’70, decide la costituzione dell’IRES, l’Istituto di ricerca della CGIL di cui – chi scrive – si onora di far parte. E poi, alcuni anni dopo, crea la Consulta giuridica della CGIL, come sede di discussione e redazione di progetti di fattibilità di alcune sue intuizioni nel campo del diritto del lavoro. Il nuovo lavoro atipico, coi suoi complessi profili sociologici e giuridici, è al centro della sua riflessione teorica e politica degli ultimi anni, quando dirigerà l’Ufficio di programma della CGIL.
Negli anni della globalizzazione e del post-fordismo scriverà contro i teorici della fine del lavoro, della liberazione dal lavoro, a sostegno della tesi della liberazione nel lavoro. Contro i nostalgici del fordismo, a favore delle nuove potenzialità che si possono dischiudere nella nuova fase in cui, a suo dire, forti permangono – purtroppo – gli elementi di un taylorismo che sopravvive al fordismo.
“La libertà viene prima”, sarà il titolo del suo ultimo libro, nel quale – confrontandosi con la teoria politica moderna – rivelerà una volta ancora la sua vecchia matrice anarchica e libertaria, dei tempi in cui leggeva Kropotkin e militava nelle formazioni partigiane di “Giustizia e Libertà”.
Ai suoi funerali, esaudendo un suo ultimo desiderio, sono stati intonati tre canti: We shall overcome; Bella Ciao; l’inno della Comune parigina del 1871.
Da «Les Mondes du Travail»